L’epistolario del celebre scrittore
“Se tu rileggi le mie passate lettere, ti farà ben maraviglia l’udire da me che mia madre, quest’unica madre e donna ha aumentato il suo amore e le sue premure per me. Eppure, la cosa è così. Io son più felice che mai”
“Sappi che, per me, il solo trovarmi in mezzo a molta gente, anche come semplice spettatore, è una cosa a cui fisicamente non posso reggere”
Se, in occasione delle celebrazioni appena concluse del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, vi è capitato di riprendere in mano I promessi sposi, un libro che non bisognerebbe mai smettere di leggere e rileggere (avete mai pensato a don Abbondio – servile con i potenti, arrogante con i più deboli – come l’antesignano dell’italiano medio incarnato da Alberto Sordi?), c’è almeno un’altra esperienza che dovete fare: addentrarvi nel suo mondo privato attraverso Tutte le lettere contenute nei tre volumi Adelphi lodevolmente curati da Cesare Arieti. Tra le varie linee labirintiche di questo sterminato epistolario, che dal settembre 1803 al febbraio 1873 attraversa tutto l’arco biografico dello scrittore – dal candido, laico e un po’ scapigliato gentiluomo diciottenne fino al celebre, venerato e religiosissimo vegliardo ormai prossimo al congedo – ho scelto quella più intimista degli affetti familiari e dei lutti di cui sono protagoniste le figure femminili della casa. Quando Alessandro raggiunge la madre Giulia Beccaria a Parigi nel luglio del 1805 ha vent’anni. Lei, fino a quel momento pressoché assente dalla vita del figlio (l’abbandono fu causa della balbuzie e di altre nevrosi), ne aveva invece quarantatré ed era affranta per la recente e prematura dipartita di Carlo Imbonati, l’amore della sua vita (da giovane aveva contratto un matrimonio d’interesse con Pietro Manzoni mentre aveva ancora una relazione con Giovanni Verri, tanto che si è sempre pensato che Alessandro fosse il figlio illegittimo di quest’ultimo anziché quello naturale di don Pietro). Nel giovane Alessandro si accende un amore ardente, edipico: le lettere di quel periodo – la maggior parte delle quali firmate come Alessandro Beccaria o Alessandro Beccaria Manzoni – sono inequivocabili: “Ho sentito veramente il bisogno di scriverti, di comunicare la mia felicità a te che me l’avevi predetta; di dirti ch’io l’ho trovata tra le braccia di una madre”, “Io non vivo che per la mia Giulia” (a Vincenzo Monti); “Questa mia dolce madre e amica” (a Claude Fauriel); “Ella è continuamente occupata… ad amarmi, e a fare la mia felicità” (a Giovan Battista Pagani); “Lei che tutto divide con me” (a Ignazio Calderari).
Fu la madre a scegliere la mite, virginale, graziosa diciassettenne Enrichetta Blondel, appartenente a una ricca famiglia ginevrina, come moglie per il figlio. Si sposarono il 6 febbraio 1808. Un mese dopo Manzoni scrive a Claude Fauriel: “Nous sommes tous les trois extrêmement heureux”. “Invece di spezzare il cerchio incestuoso”, scrive Pietro Citati in La collina di Brusuglio, “il matrimonio lo rese dunque più forte, complicato e intricato”. Enrichetta garantì al marito una vita serena (“Ho trovato una compagna che riunisce tutti i pregi che possono rendere veramente felice un uomo, e me particolarmente; mia madre è guarita affatto; e non regna fra di noi che un amore ed un volere”, ancora a Giovan Battista Pagani) e gli diede nove figli. La sua morte per tubercolosi, avvenuta dopo una lunga agonia il giorno di Natale del 1833 all’età di 42 anni (“mi pareva che dal sentimento dell’amore fosse agevole immaginare il sentimento della perdita; ma veggo ora che la sventura è una rivelazione tanto più nuova quanto più grave e terribile”, a Leopoldo II Granduca di Toscana), fu meno gravida di conseguenze rispetto a quella della ‘mater familias’ (7 luglio 1841): “La prima lettera ch’Ella mi fece l’onore di scrivermi mi trovò in dolorose inquietudini, le quali non terminarono che in pieno e permanente dolore” (a Gabrielangelo Gabrielli). È uno spartiacque: prima c’era stato il periodo più roseo, rappresentato dalla scrittura e riscrittura dei Promessi sposi, dopo si sarebbe consumato il romanzo più nero della famiglia. Preceduta dai decessi della piccola Clara di due anni (1° agosto 1823) e proseguita con la primogenita Giulia, moglie di Massimo d’Azeglio, all’età di 27 anni (20 settembre 1834, “È piaciuto al Signore di ritirar dal mondo la mia figlia maggiore, nel fior degli anni, sui principii d’un fortunatissimo matrimonio e d’una sviscerata maternità”, a Leopoldo II Granduca di Toscana), la funesta serie delle morti delle figlie sarebbe proseguita con la ventisettenne Cristina (27 maggio 1841), la ventisettenne Sofia (31 marzo 1845) e la venticinquenne Matilde (30 marzo 1856). Nemmeno la passione e la dedizione verso la seconda moglie, Teresa Borri (Manzoni le ha scritto un’ottantina di lettere, a Enrichetta nessuna), che ebbe un rapporto non di rado conflittuale con la famiglia, fu indenne dalla sventura e dal dolore: il 18 febbraio 1845, Teresa, a causa di una diagnosi sbagliata (un tumore in luogo di una gravidanza gemellare), partorì due bambine, “una delle quali visse alcune ore, l’altra fu battezzata sub conditione”. L’anno dopo la figlia Vittoria sposa Giovan Battista Giorgini e si trasferisce con il marito in Toscana, portando con sé la cagionevole Matilde: il nucleo familiare si è dissolto e i figli maschi Enrico e Filippo aggravano con comportamenti scellerati la già precaria situazione finanziaria del padre. A Filippo, che aveva già conosciuto a 26 anni il carcere per debiti e che vive di espedienti e raggiri, Manzoni scrive: “La tua lettera del 26 luglio mi fece pur troppo vedere sempre più quanto tu sia lontano dall’avere, non dico un giusto, ma un mediocre sentimento dei dolori che mi hai così perseverantemente e così inflessibilmente cagionati”. A Enrico, scialacquatore di beni, doti e patrimoni (morì nel 1881 quasi cieco in preda all’alienazione mentale): “Ho ottantacinque anni; e tu stesso dovresti essere contento di compensare, col lasciarmi morire in pace, il non avermi lasciato vivere in pace per tanti anni, non solo per i dispiaceri che mi vennero direttamente da te, ma per le tante e tante persone che m’hai tirate addosso, e che furono uno de’ più penosi esercizi della mia vita”. Fu, insieme a Vittoria (la più longeva), l’unico figlio che sopravvisse al padre: gli altri, come anche la seconda moglie (seppellita nel 1861), erano tutti morti, compreso il secondogenito Pietro, il suo prediletto, che se ne andò un mese prima di lui all’età di 59 anni.
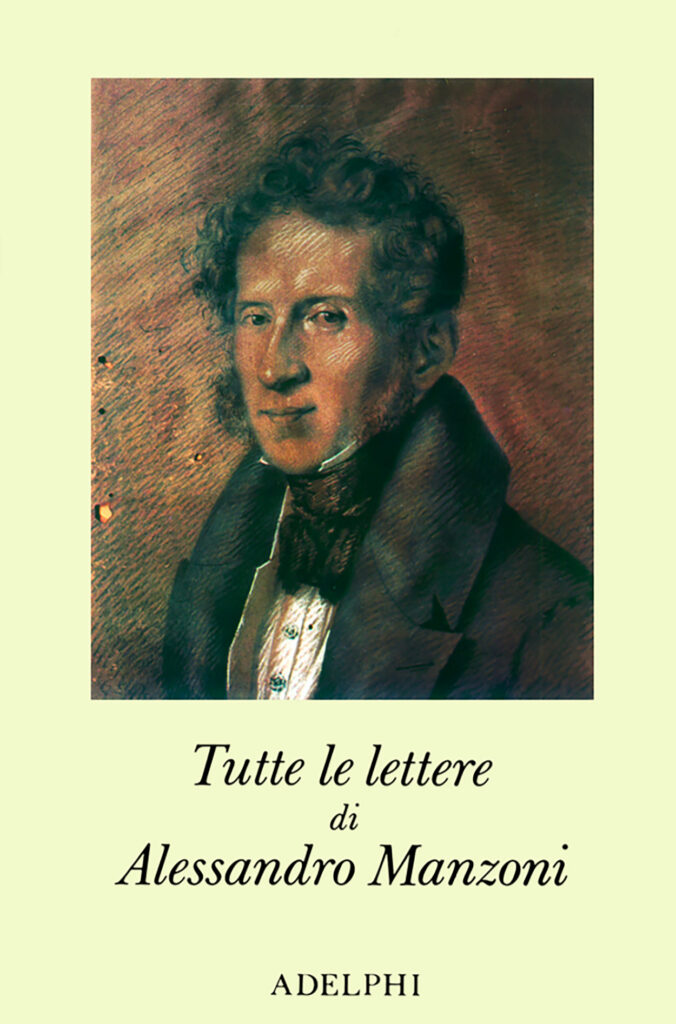
Alessandro Manzoni, Tutte le lettere, a cura di Cesare Arieti, con un’aggiunta di lettere inedite e disperse a cura di Dante Isella, tre volumi rilegati in cofanetto, pp. xv-3384, Adelphi, Milano 1986, € 130.


















