Manganelli e Pirandello, tra euforia e disperazione
“Eccoti, Ebe, la lettera per Ebe: vorrei che tu, chiudendola,
ti trovassi sui polpastrelli il segno dell’ustione”
Giorgio Manganelli
È uscito qualche mese fa per Sellerio Mia anima carnale, le venti lettere che Giorgio Manganelli scrisse a Ebe Flamini tra l’agosto del 1960, quando il proteiforme scrittore stava lavorando all’Hilarotragoedia, suo esordio letterario del 1964 (avrebbe firmato il contratto di Feltrinelli con la nuova stilografica regalatagli dall’amata), e l’8 marzo del 1973, quando Manganelli aveva già alcuni libri rivoluzionari all’attivo (La letteratura come menzogna, Nuovo commento, Agli dei ulteriori), aveva lasciato l’insegnamento negli istituti tecnici e l’incarico come assistente di letteratura inglese presso l’Università La Sapienza di Roma, stava uscendo dall’orbita Einaudi di cui era autore e consulente, e soprattutto aveva già da qualche anno un’altra impellente relazione, quella con l’anglista Viola Papetti: contrariamente al suo physique du rôle, tutt’altro che avvenente, Manganelli, “un mandrillo con gli occhiali” come lui stesso si definiva, era un seduttore impenitente e rapinoso – quasi una reazione, un contrasto o una fuga dalla figura opprimente del “vipistrello” materno. Le lettere – di variopinta geografia: arrivano da Roma, Torino, Mombasa (“nessuno può descrivere la qualità più schiacciante del mondo africano, la sua dimensione: qualcosa di preistorico, di preumano. Il cielo è basso, lo si porta sulla nuca; le piogge, furibonde e indifferenti”), Addis Abeba (“città mostruosa, modernissima, viali da Cristoforo Colombo, vetri, grattacieli, Hilton”), Malacca (“è una delle cose più straordinarie, più struggenti, più fascinose che abbia mai visto”), Manila – furono ritrovate in una scatola di cartone nel sottoscala della casa di Ebe dalla nipote Patrizia Moretti e affidate a Salvatore Silvano Nigro, che ne ha curato un’edizione impeccabile.
Sono lettere passionali, euforiche, accese da un’incandescenza erotica, sensuale e affabulatoria, gioiosa, maliziosa e carnale, che possono sorprendere chi conosce Manganelli come il cantore delle fangose paludi dell’essere. Ebe, nome palindromo che si presta a invocazioni e anafore, è di volta in volta “mia patologia”, “mia alterazione febbrile”, “mio amore”, “luogo per carezze”, “collina da descrivere con movimenti di mani, scaltre e amorose, competenti e scattanti”, “sole portatile per tutte le sere della vita”, “sugoso frutto autunnale, di quelli che abbisognano di gran tempo per maturare tutti i loro succhi intrinseci”.
Soprattutto, “Ebe è il nome di un corpo: il corpo di Ebe è amore, e violenza, è caverna, e gorgo, fosforescenza, è geometria ed è foglia – è l’aprirsi, nell’aria, di una voragine precipitosa e mansueta”. Ne descrive “il ventre di lene convessità”, “il lucus numinoso del pube: di vegetazione da rada a folta, luogo d’ombra, squassato dal sotterraneo pulsare di quell’intimo speco”, “l’ingresso nelle tue viscere buie e calde, l’angusto corridoio senza luce che porta a luoghi ctonii, la discesa lùbrica e tenera di una cavità colma di violente e amorose presenze”, “le tue acque interiori, mia donna, notturne e tropicali”.
Nessuno, nemmeno nelle cose dell’amore e del sesso, scriveva come Giorgio Manganelli.
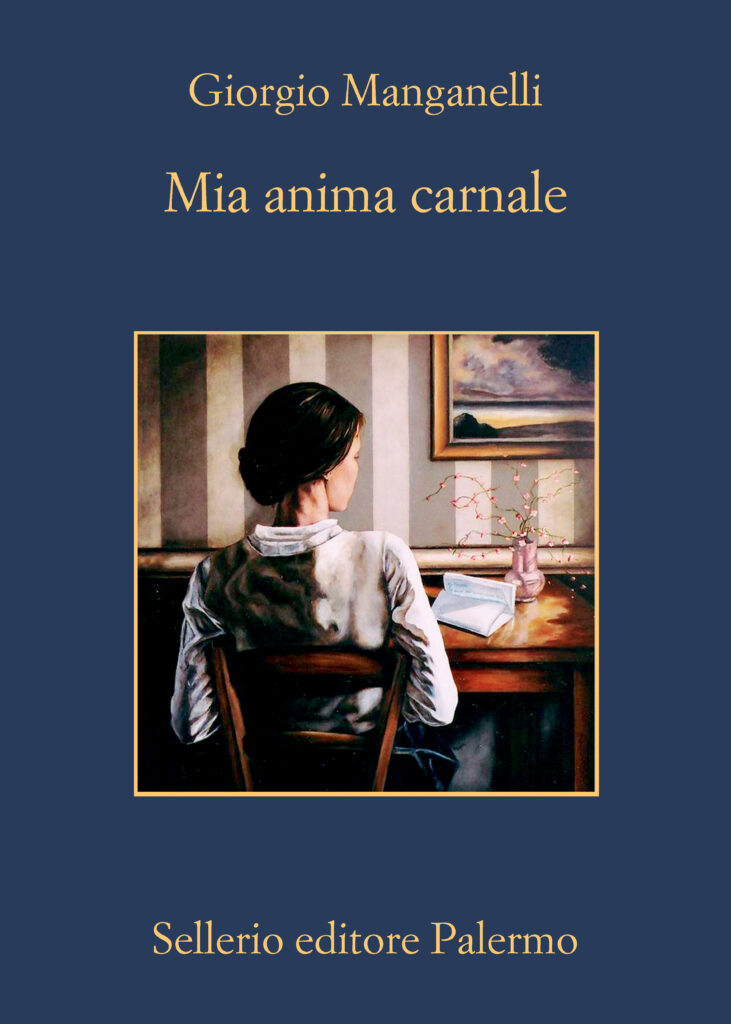
Giorgio Manganelli, Mia anima carnale. Lettere a Ebe, Sellerio, Palermo 2023, pp. 116, 13 €
“Vivo con tutta l’anima protesa e intenta a Te: non penso ad altro; e tutto ciò che
m’avviene lo riferisco a Te, come alla fonte unica della mia vita.
Credo che non si possa dare un assorbimento così totale
d’una vita in un’altra, come della mia nella Tua”
Luigi Pirandello
Leggendo le missive di Manganelli mi sono tornate in mente, per contrasto, le Lettere a Marta Abba che Luigi Pirandello scrisse nell’arco di un decennio, dal 5 agosto del 1926 al 4 dicembre del 1936, pochi giorni prima della morte. Non potrebbero esistere due epistolari d’amore più antitetici per stile, corpus, sentimento. Alle 20 lettere di Manganelli, scritte in stato euforico dai quattro angoli esotici del pianeta, si oppongono le 552 che Pirandello scrisse da stanze d’albergo, spesso lontane dall’Italia, in cui misurava la propria dolente solitudine. Il fluviale epistolario, ottimamente curato da Benito Ortolani (introduzione, note, commenti, indici), occupa più di 1.500 pagine (ma la mole non deve intimorirvi: queste epistole sono di una ricchezza, anche letteraria, assoluta) di uno dei Meridiani Mondadori dedicati all’intera opera dello scrittore siciliano, l’unico che non ne riporta il ritratto sul cofanetto: al suo posto c’è una fotografia di Marta Abba. Non è un caso: Pirandello si annulla davanti alla figura idealizzata di lei, al suo ricordo, alla sua assenza. Il drammaturgo e l’attrice si conobbero nel febbraio del 1925: lui aveva 57 anni, lei 24 e divenne la prima attrice del suo “Teatro d’Arte”. Nell’ottobre del 1928 partirono insieme alla volta di Berlino per conquistare la gloria mondiale e tornare in Italia come trionfatori. Ma il 13 marzo del 1929, dopo una difficile convivenza in camere separate d’albergo (lei era accompagnata dalla sorella Cele) e diverse delusioni in campo professionale, Marta lascia Pirandello, abbandonandolo al più tetro sconforto. “Il silenzio della stanza accanto, dove fino a poche ore fa Tu avevi abitato, mi dava il senso della morte. Mi sono sfogato a piangere per ore e ore”.
Le lettere più strazianti sono di questo periodo. Di fronte al suo dolore lei si dimostrò altera, distante, spietata: gli si rivolgeva con il “lei”, non voleva che lui firmasse le lettere con il proprio nome, pretendeva che strappasse quelle che gli inviava, non voleva sentir parlare di sentimenti, che giudicava “chiacchere inutili”, solo di lavoro: protezione, opportunità, progetti. Lo scrittore al tempo più famoso e celebrato, Premio Nobel per la letteratura, un uomo che poteva avere il mondo ai suoi piedi, si gettò davanti a quelli della sua protetta, trasformandola in un’ossessione. La implora costantemente di scrivergli per sentire meno la terribile distanza che li separa, precipita nella protrazione e nell’umiliazione, in quell’”atroce solitudine” e in quell’”abisso di disperazione” che ancora lamenta nell’ultima lettera datata 4 dicembre 1936, sei giorni prima di spirare, dove lui è ancora lì a giustificarsi per avere o non avere fatto questo o quello, a placare le sue rimostranze (impazziva al solo pensiero di deluderla), ad adoperarsi con dedizione assoluta unicamente a lei (“Io non penso che a Te, non bado che al Tuo interesse, esclusivamente, e non mi preoccupo d’altro”). Impossibilitato ad amarla, incapace di lasciarla, Pirandello venerò la sua musa come una dea, un sacrificio che sconfinò nell’adorazione, nella glorificazione, nell’esaltazione (“Io risorgerò; son già risorto; io sono ancora il primo; sarò sempre il primo, perché Dio m’ha dato il dono d’essere primo, e nessuno me lo potrà levare. Io solo so scrivere ancora grandi e nuove cose. E se io sono il primo, Tu devi essere la prima, per forza!”). Un’arte al servizio di una divinità “dalla bocca sigillata e senza sorriso”, e del suo culto.

Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, Meridiani Mondadori, Milano 1995 e 2001, pp. xliv-1660, con 11 fotografie in bianco e nero, rilegato con astuccio, 80 €


















